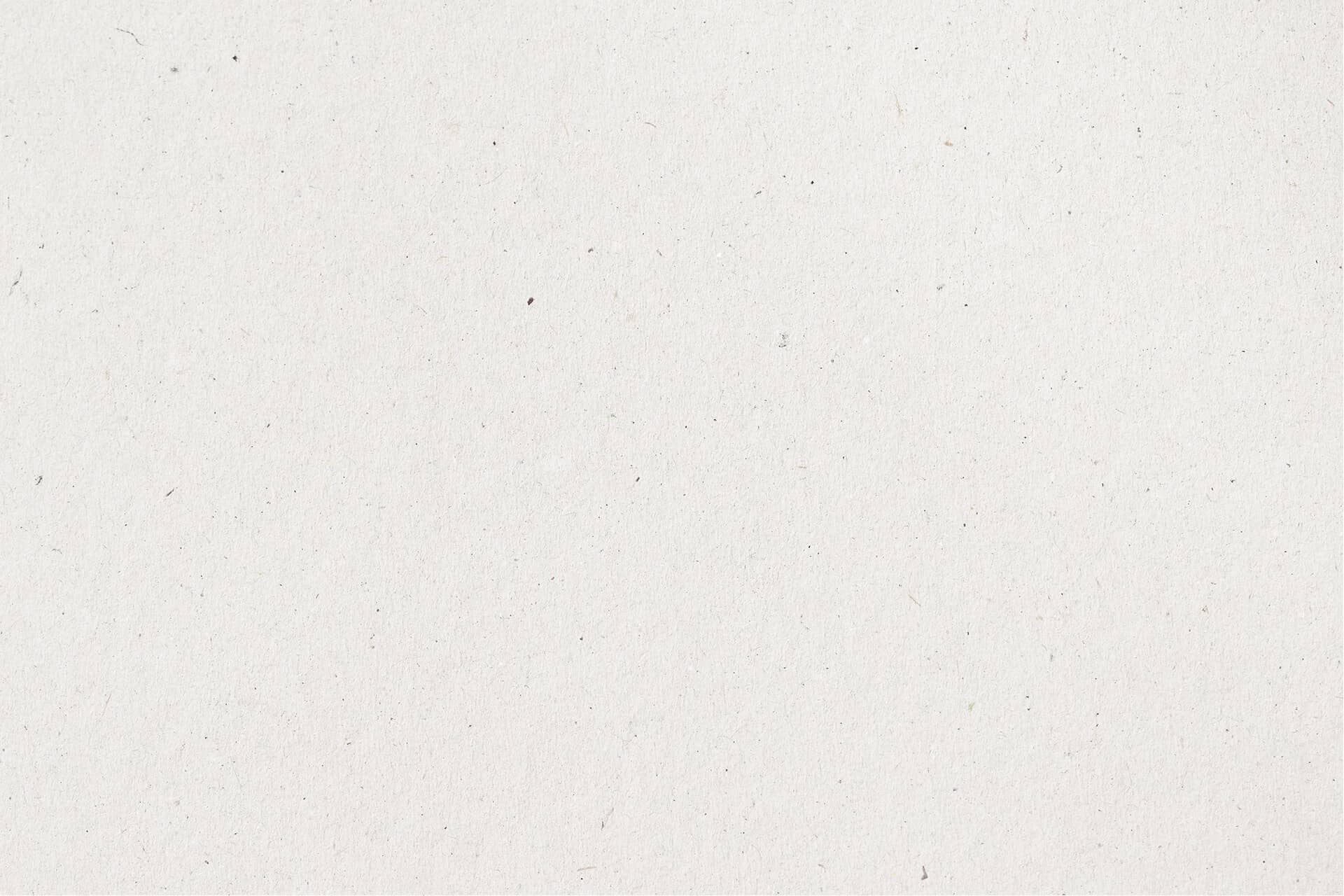
Il mio blog: un baule dove condivido letture, ricerche e ciò che sto imparando.

Lettera alla Riviera Maya del 2010
Coralli che non ci sono più, sargassi che insistono e perché continuo a progettare viaggi
Nel 2010 viaggiai con mio padre nella Riviera Maya per completare la certificazione subacquea. Ci immergemmo in quella che era conosciuta come la seconda barriera corallina più grande del mondo. Quattro immersioni indimenticabili: nuotammo accanto a tartarughe giganti, attraversammo tunnel naturali formati dai coralli e, facendo parasailing, vedemmo dall’alto l’immensità dei Caraibi messicani, con le sue fasce turchesi, blu cobalto e verde smeraldo.
Per quattro giorni di corso pagai 400 dollari per imparare a respirare sott’acqua davanti a quella meraviglia. La frase —“seconda barriera più grande del mondo”— l’avevo trovata la sera prima su Wikipedia, emozionata all’idea di avere un simile tesoro a sole nove ore da Buenos Aires. Era un privilegio poterlo vedere, averlo in America.
Gli operatori turistici preferivano altri aggettivi: “acque cristalline”, “biodiversità unica”, “esperienza indimenticabile”.
Imparai che l’azoto può ucciderti se risali troppo in fretta, che le murene possono confondere il tuo dito con un pesce, che non bisogna mai toccare il corallo. Nessuno disse che quel corallo che non dovevamo toccare stava già morendo. Il silenzio era parte del prodotto. Avevamo pagato un sogno, non una lezione di ecologia.
Cozumel, con le sue famose pareti di corallo, rimase in sospeso. Ma già allora sapevamo che i coralli erano in pericolo.
Il ritorno e le brigate invisibili
Tornai nel 2017, questa volta a Tulum, anche se non potei immergermi. Con Google Maps e la volontà di evitare le folle, trovai una spiaggia che gli algoritmi definivano “gemma nascosta”. Alle sei del mattino, aspettando l’alba, scoprii un’altra scena: brigate di pulizia.
Quattro uomini con rastrelli e un pick-up raccoglievano montagne di alghe prima che arrivassero i primi turisti. Lavoravano in silenzio, efficienti, invisibili. Quando chiesi, uno mi disse: “È temporaneo, señorita. Cosa di correnti.” Ma i suoi occhi dicevano altro. Era il 2017 e i sargassi arrivavano da sei anni. Quanto dura il “temporaneo” quando nessuno vuole nominarlo?
Vivendo in Messico, capii che i sargassi non erano più un problema stagionale, ma una crisi che attraversava ogni conversazione sul turismo caraibico. La domanda non era più se sarebbero arrivati, ma come nasconderli.
Il nuovo vocabolario dei Caraibi
Appresi un linguaggio codificato del settore:
- “Condizioni naturali variabili” (ci sono sargassi).
- “Esperienza autentica dei Caraibi” (vedrai la realtà che non compare nelle cartoline).
- “Stagione di rinnovamento costiero” (non venire in questi mesi).
- E la più cinica: “Opportunità di scoprire altre attrazioni.” Come se il collasso ecologico fosse un invito a comprare più escursioni.
Ciò che mi colpiva: si parlava sempre di impatti economici, quasi mai di impatti ambientali. E raramente della barriera corallina.
La cintura dei sargassi
Dal 2011, spiagge un tempo considerate tra le più pulite al mondo hanno iniziato a ricevere tonnellate di alghe galleggianti chiamate sargassi. Quello che all’inizio sembrava un’anomalia si è trasformato in un modello annuale, con conseguenze sempre più gravi.
I sargassi —Sargassum natans e Sargassum fluitans— sono sempre esistiti, galleggiando nell’Atlantico del Nord come parte di un ecosistema sano. Il problema è la scala: l’eccesso di nutrienti dal bacino dell’Amazzonia e dell’Orinoco, il riscaldamento globale, le correnti modificate. Tutto si è combinato creando la Great Atlantic Sargassum Belt, una fascia di oltre 8.000 chilometri di alghe —grande quanto 800 volte Buenos Aires— che ogni anno si sposta dall’Africa ai Caraibi.
Non copre solo le cartoline turistiche. Blocca la luce solare necessaria ai coralli, rilascia gas tossici decomposta, altera il pH dell’acqua, favorisce batteri che competono con gli stessi coralli. Tutto questo mentre la Barriera Mesoamericana soffre già di sbiancamento, acidificazione e inquinamento.
In Martinica una scuola dovette chiudere per i gas. A Barbados l’occupazione alberghiera crollò del 40% mentre il sargasso veniva rimosso a camionate. Nelle Piccole Antille i pescatori lottavano con reti intrappolate. E su Instagram, i Caraibi sembravano immutati.
Le domande che cambiano
Nel 2010 chiedevo: Dove c’è la miglior visibilità? A che profondità stanno le tartarughe? L’acqua è calda?
Ora chiedo: Perché l’acqua è ogni anno più calda? Quali storie non vengono raccontate? Per chi esiste questo paradiso? La mia presenza accelera la sua degradazione?
A volte penso che la mia certificazione subacquea sia stata anche un documento storico: Certified Open Water Diver, Riviera Maya, 2010. Traduzione: autorizzata a esplorare un mondo che è esistito.
Viaggiare per ricordare
Il sargasso non è solo un fastidio estetico. È un messaggero che insiste nel parlare mentre noi perfezioniamo l’arte di non ascoltare. Come il cambiamento climatico, sembra enorme, complesso, inafferrabile. Ma qualcosa è alla nostra portata: smettere di distogliere lo sguardo. Nominare ciò che sta accadendo. Ricordare. Perché a volte ricordare un corallo è anche un modo di provare a salvarlo.
Mentre i Caraibi imparavano a nascondere la loro ferita, io cercai un altro mare. Sul Pacifico, il Mar di Cortez mi rivelò una biodiversità che i Caraibi avevano già perso. A La Paz —non a Los Cabos con i suoi resort all-inclusive— nuotai con i leoni marini, vidi saltare le mante, capii che l’equilibrio è ancora possibile in certi luoghi.
Non è che il turismo da resort sia l’unica causa del collasso. Ma quando un luogo diventa palcoscenico di consumo irriflessivo —drink, feste, selfie— perde la capacità di insegnarci, di trasformarci. E senza trasformazione, perché viaggiare?
Viaggi con memoria
In HeySole! progetto viaggi per chi, come me, cerca più delle sole acque cristalline. Per chi capisce che viaggiare significa anche testimoniare, fare domande, creare memorie consapevoli.
Perché conoscere un luogo non è solo sapere dove mangiare il miglior ceviche o trovare la spiaggia meno affollata. È comprenderne i silenzi, le trasformazioni, le bellezze e le ferite.
Se questo testo ti ha fatto riflettere in modo diverso su come viaggiamo, condividilo. Perché ricordare un corallo è anche un modo di prendersene cura.

Imparare a sfidare il canone per costruire la biblioteca (e il passaporto)
Leggere e visitare i classici per sviluppare il proprio gusto
Nel mio primo grand tour europeo evitai le destinazioni che figurano prime nella bussola della maggioranza dei latinoamericani: Spagna e Italia. Mi lanciai a -20 gradi, strati di neve che non avevo mai visto, culture diverse. Fu divertente da ogni angolo. Ma solo quando arrivai in Italia l’anno seguente compresi il magnete: non era solo il romanticismo delle radici, era la densità culturale che avevo già intuito nei libri, quella che riconoscevo dalla mia educazione e dalle mie radici. Leggere Dante, Cervantes, Virgilio era stata teoria; in Italia divenne paesaggio, e tutto si chiuse.
Rivedendo la mia biblioteca, scoprii che la mia prima ondata fu, prevedibilmente, il canone che ci invitano a leggere quando ci immergiamo nella letteratura. C’era García Márquez con il suo Macondo di violenze cicliche, dove il magico era l’unica forma di narrare il latinoamericano. I salotti del Bloomsbury Group, dove Virginia Woolf discuteva come vivere e scrivere diversamente, e Huxley criticava con un piede dentro. La febbre nordamericana degli anni venti, tra cocktail clandestini e vestiti di paillettes. La critica delle radici sanguinose del continente: il silenzio desertico di Rulfo, il sangue di Fuentes, L’Avana di Padura. E prima di tutto questo, Omero, navigando il Mediterraneo di eroi erranti e viaggi senza fine.
Rivedendo la mia biblioteca, scoprii che la mia prima ondata fu, prevedibilmente, il canone che ci invitano a leggere quando ci immergiamo nella letteratura. C’era García Márquez con il suo Macondo di violenze cicliche, dove il magico era l’unica forma di narrare il latinoamericano. I salotti del Bloomsbury Group, dove Virginia Woolf discuteva come vivere e scrivere diversamente, e Huxley criticava con un piede dentro. La febbre nordamericana degli anni venti, tra cocktail clandestini e vestiti di paillettes. La critica delle radici sanguinose del continente: il silenzio desertico di Rulfo, il sangue di Fuentes, L’Avana di Padura. E prima di tutto questo, Omero, navigando il Mediterraneo di eroi erranti e viaggi senza fine.
Questa è la base indiscussa: orienta, dà indizi, a volte annoia e a volte accende. Ma è la mappa iniziale che ognuno deve accettare o sfidare prima di tracciare la propria biblioteca. Nella maggior parte dei casi, il canone si trasforma in un faro. Da lì scopriamo il gusto proprio e approfondiamo uno stile di narrativa (e di viaggi). Nella mia biblioteca brillano i romanzi-saggio, con La Montagna Incantata e le sue mille pagine che mi invitano a dibattere sulla cucina dell’Europa pre-prima guerra. Il grande libro aperto sul mappamondo pieno di spilli e desideri è Roma, la città dove sono tornata dodici volte. Dal mondo romano al rinascimento, al barocco, alla repubblica, non c’è buco storico che non mi catturi.
Per riempirmi di qualcosa ho bisogno di densità. Dopo letture e viaggi per il vecchio e nuovo mondo, ho imparato che ciò che mi piace è quello che va oltre, che riflette oltre a intrattenere, che ha strati, e a seconda del momento della vita, si può godere ogni volta da un angolo diverso.
Ho visto qualche giorno fa sui social qualcuno che si chiedeva perché Monaco di Baviera non figura nei percorsi europei essenziali, e credo che la risposta stia nel canone. La narrativa tedesca che impariamo ci porta prima a Berlino: il Muro, la memoria storica, il peso del XX secolo. Ma Monaco è un’altra Germania, ugualmente densa: capitale della Baviera, specchio della sua architettura, dei suoi festival gastronomici e delle sue tradizioni folcloristiche. Sa abbracciare il presente senza rinnegare il passato. La lettura che più riflette Monaco nella mia biblioteca è, appunto, Thomas Mann. Combina radici germaniche, eleganza borghese, tensione con la modernità e quell’aria di città che beve birra sotto i castagni mentre custodisce collezioni di pittura gotica, biblioteche infinite e sedi di aziende tecnologiche. La Germania dove tradizione e modernità convivono in tensione appare come un secondo strato, meno evidente, ma ugualmente imprescindibile.

Appunto, costruire la propria collezione di libri, racconti, culture, comunità, città e paesaggi richiede audacia ed energia. Non lo dico in senso snob, ma pratico: serve tempo, risorse e anche curiosità.
A volte serve persino coraggio per rispondere a domande scomode quando usciamo dal percorso che tutti si aspettano: perché leggi quell’autrice contemporanea e non Proust? Di nuovo in Toscana quando ancora non sei stata in Galizia? Ma quel Faust che questiona sta principalmente in noi, con domande interne: investo il mio prezioso tempo libero a scoprire se mi risuonano le Alpi francesi, svizzere, italiane o austriache? E se fosse tutto uguale?
In quel piccolo esempio c’è un mondo: di quali Alpi svizzere parlo? Della bellezza e del lusso di St. Moritz sul lago ghiacciato, dove carrozze di cavalli disputano il premio mentre assaporiamo spumante servito da un cameriere sui pattini? Della vita di sci e alpinismo di Zermatt, il paese coscienzioso con l’ambiente dove i pochi veicoli sono elettrici, e la vista costante del Cervino ci ricorda che è quella la natura che vogliamo mantenere incontaminata?
Sebbene abbia visitato St. Moritz brevemente tre volte, senza dubbio passerei settimane e settimane in diverse stagioni sotto il Cervino, camminando per i suoi sentieri, scivolando sulle piste, scoprendo le facce italiane e le vette francesi dall’alto. Non è che il lusso mi metta a disagio, ma non ho trovato in esso la vitalità che ho trovato a Zermatt.
Nelle fotografie tutto sembra bello, non c’è dubbio. Ma vivendolo, come girando le pagine di un libro, scopriamo cosa ci apre la curiosità. Una curiosità che si alimenta di camminate, domande ai locali, letture, e dove io trovo il piacere. Il cammino, a volte, può essere pesante. Ci sono nebbie in cui leggiamo o visitiamo solo perché tutto il resto lo fa. Non tarda ad arrivare quel momento da segugio in cui si fiuta cos’è il tuo. Per istinto, guidati da librai, amici lettori, viaggiatori, o un’amica curiosa come me, puoi arrivare al tuo tartufo.
Ho trovato così María Gainza: prettamente porteña, amante dell’arte, critica sociale, saggista autobiografica che gioca con la letteratura. Dalle prime pagine di El nervio óptico mi resi conto che quelle analisi di opere d’arte dei musei di Buenos Aires intrecciate con racconti autobiografici un po’ satirici mi catturavano. La bellezza architettonica e il potere politico del breve regno dei Savoia che comunque unificò l’Italia, mi portarono a Torino a mangiare gianduiotti (e tartufi bianchi nella vicina Alba). Scoprire questi gioielli, da sola, valse ogni lettura e ogni viaggio. Il rischio di sbagliare è sempre nell’aria, ma la ricompensa è così grande che continuo ad annusare il vento, cercando qual è il prossimo tesoro dove mi porterà il mio olfatto.
Non si tratta di collezionare destinazioni o autori prestigiosi. Si tratta di riconoscere cosa ti fa sentire più vivo, più curioso, più te stesso.

Quale luogo o libro ti ha fatto capire che potevi tracciare la tua mappa?

Il Porto che nacque vecchio: quando Buenos Aires scelse il prestigio sulla funzione
Una storia di decisioni urbane, fallimenti necessari e il coraggio di reinventarsi
Sapevi che Buenos Aires scelse di costruire un porto che non avrebbe funzionato solo per assomigliare all’Europa? Questa è la storia di Puerto Madero: quando il prestigio vinse sul pragmatismo… e come quel “fallimento” divenne la trasformazione urbana più audace dell’America Latina.
Nel 1882, due progetti si contesero non solo il porto di Buenos Aires, ma l’idea che la città aveva di sé stessa. Luis Huergo—ingegnere, pragmatico—proponeva moli rettilinei che seguissero la geografia del fiume: funzionali, economici, pensati per una città-porto che cresceva dal lavoro. Eduardo Madero—nipote del vicepresidente Francisco Madero, ben posizionato—immaginava darsene chiuse stile Liverpool: simmetriche, ornamentali, degne di una capitale che guardava sempre all’Europa prima di capire sé stessa.
La battaglia tra pragmatismo creolo e prestigio importato la vinse Madero. Tra il 1887 e il 1898, gli architetti inglesi John Hawkshaw e Harrington Hayter progettarono da Londra un porto che l’impresa Thomas Walker & Co. costruì con dock di mattoni rossi che sembravano cattedrali industriali trapiantate dall’Inghilterra. Le gru Armstrong Whitworth presiedevano un porto bello ma disfunzionale: era scenografia prima che infrastruttura.
Nel 1911 stavano già costruendo Puerto Nuevo seguendo—ironia del destino—le idee di Huergo. Nel 1925, le ultime navi abbandonarono le darsene di Madero. Il porto nato per impressionare rimase come reliquia urbana: più di 60 anni di abbandono, con capannoni monumentali occupati da intere colonie di ratti, nel cuore di una città che preferiva non guardare verso il fiume.
L’archeologia dell’abbandono
Mia nonna lo vedeva dal suo ufficio all’ANMAT: quel paesaggio di abbandono che Buenos Aires aveva naturalizzato. Capannoni di mattoni morsi dall’umidità, strutture metalliche che arrugginivano all’aperto, erbacce che crescevano tra i binari ferroviari. Era il rovescio esatto del porto sognato: il luogo dove la città custodiva il suo fallimento più visibile.
Per più di mezzo secolo, Puerto Madero fu l’inconscio urbano porteño. Lì stavano le conseguenze di scegliere l’apparenza sulla funzione, il prestigio sul pragmatismo. La decisione del 1882 si era trasformata in rovine, e le rovine erano diventate normalità.
Ma le città, come le persone, a volte hanno bisogno di toccare il fondo per potersi reinventare.
Il laboratorio della reinvenzione
Nel 1991, quando la Corporación Antiguo Puerto Madero—modello di gestione mista inedito in Argentina—decise che era il momento di trasformare quel bordo urbano, non si trattava solo di recuperare edifici. Era ridefinire che città volevamo essere. Di nuovo, la geografia come politica; l’urbanismo come autoritratto.
Mio padre si trasferì vicino a Puerto Madero alla fine degli anni ‘90, quando le gru ancora disegnavano lo skyline e ogni passeggiata era archeologia del futuro. Andavamo a vedere crescere le torri El Faro, a camminare sul Puente de la Mujer come se fossimo i primi a calpestarlo, a vedere come i vecchi silos di Molinos diventavano loft con le gru Armstrong Whitworth ancora presenti come testimoni silenziosi delle due epoche che visse questo luogo: l’industriale e il residenziale.

I parchi dalle linee rette e prato millimetrico erano il nostro laboratorio di modernità: una Buenos Aires senza marciapiedi rotti né angoli improvvisati. Ma anche qualcosa di più: spazi verdi pianificati dove prima c’era solo abbandono, passeggiate pedonali che collegavano la città con il fiume, infrastruttura culturale che democratizzava l’accesso all’arte contemporanea.
Perché Puerto Madero non è solo torri corporative e ristoranti sulla darsena—anche se quella è la cartolina più venduta. È anche il Museo Fortabat con arte argentina di primo livello, la Riserva Ecologica che si autorigenerò sulle macerie, i sentieri per correre dove chiunque può allenarsi gratis, la Fontana delle Nereidi che migrò da Plaza de Mayo per trovare il suo posto definitivo di fronte al fiume, la storica fregata Sarmiento che racconta la storia navale argentina.

Oltre la cartolina turistica
Dopo mi trasferii vicino e Puerto Madero divenne la mia pista da corsa mattutina, il mio rifugio verde in una città che respira cemento, la mia connessione diretta con il fiume senza mediazione di semafori. Lì capii che questo quartiere ha molteplici strati d’uso, non tutti visibili nelle guide turistiche.
Alle 7 del mattino, mentre i camerieri vestiti da gaucho ancora dormono, Puerto Madero appartiene ai runner, a chi porta a spasso i cani, ai pensionati che fanno tai chi di fronte al fiume. Alle 8, si riempie di impiegati che camminano verso i loro specchiati edifici corporativi. Alle 6 del pomeriggio, è territorio di famiglie che cercano spazio libero perché i bambini vadano in bicicletta. I fine settimana, si trasforma in destinazione di riposo: picnic, pedalate e mate.
È gentrificazione? Sì, anche. Ma è più complesso di così.
La politica della trasformazione urbana
Qui sta la tensione che definisce Puerto Madero e che, in realtà, definisce ogni trasformazione urbana di successo: può uno spazio essere simultaneamente esclusivo e inclusivo? Può la pianificazione statale convivere con l’investimento privato senza che una annulli l’altra?
Per molti porteños, Puerto Madero continua a essere ostentazione vuota, un non-luogo che non gli appartiene, un esperimento immobiliare travestito da quartiere. E hanno parzialmente ragione: è caro vivere lì, molti ristoranti puntano al turismo, l’estetica in alcuni casi sembra forzata.
Ma è anche vero che dove prima c’era terreno incolto ora ci sono 28 ettari di spazi verdi pubblici dentro il progetto Puerto Madero. Che la Costanera Sur, che passò da balneario elegante negli anni ‘20 a zona emarginata negli anni ‘70, oggi è parte del maggior complesso di spazi verdi del centro porteño insieme alla Riserva Ecologica di 350 ettari. Che l’arte argentina ha uno spazio di esibizione (il Museo Fortabat) che prima non esisteva. Che migliaia di persone possono accedere al fiume in una città che storicamente diede le spalle all’acqua.

Una delle nuove passerelle della Riserva Ecologica.
Lezioni di un fallimento convertito in opportunità
La vera lezione di Puerto Madero non è che la trasformazione urbana sia buona o cattiva di per sé. È che le città, come gli organismi vivi, hanno bisogno di evolversi o muoiono. E che a volte, paradossalmente, il fallimento più clamoroso può convertirsi nell’opportunità più preziosa.
Buenos Aires scelse male nel 1882. Costruì un porto inglese in geografia rioplatense, diede priorità all’immagine sulla funzione, scommise sul prestigio importato invece che sull’innovazione locale. Il risultato fu prevedibile: un porto che non funzionò, che divenne obsoleto prima di compiere 40 anni.
Ma quell’errore divenne, un secolo dopo, la materia prima di una delle trasformazioni urbane più audaci dell’America Latina. I capannoni vittoriani abbandonati si convertirono in loft e centri culturali. Le darsene disfunzionali si trasformarono in specchi d’acqua che moltiplicano il cielo. I binari arrugginiti divennero sentieri verdi.
La geografia del presente
Io insisto che Puerto Madero è da vivere: per respirare l’aria che viene dall’acqua, per vedere arte tra darsene storiche, per capire che a volte una città ha bisogno di inventarsi spazi dove non esistevano. Non è nostalgia né speculazione pura: è geografia del presente, un pezzo di Buenos Aires che osò non assomigliare a nessun altro.
È perfetto? No. È inclusivo? Non completamente. Ha risolto tutti i problemi urbani di Buenos Aires? Ovviamente no.
Ma sì riuscì a fare qualcosa che sembrava impossibile: restituire il fiume a una città che aveva dimenticato di essere portuale. E questo, in una metropoli di 15 milioni di abitanti, non è poca cosa.
La prossima volta che cammini per Puerto Madero—sia per correre, per vedere una mostra o sì, anche per mangiare in uno di quei ristoranti con vista sulla darsena—ricorda che stai calpestando la materializzazione di una domanda che tutte le città si fanno: chi siamo e chi vogliamo essere?
Buenos Aires impiegò 109 anni a rispondere. Ma quando lo fece, costruì non solo un quartiere nuovo, ma un nuovo modo di pensarsi.

E raccontami: hai qualche esperienza personale di Puerto Madero? O qualche luogo della tua città che è cambiato completamente e ti genera sentimenti contrastanti? Amo leggere queste storie nei commenti.
Se questa storia ti ha risuonato, condividila. Sicuramente conosci qualcuno che ha bisogno di riscoprire la propria città con occhi diversi.

Svizzera senza fretta: treni, valli e l’eleganza di un paese che funziona senza ostentazioni
Un taccuino lento di treni panoramici, villaggi alpini e fortezze medievali. Oltre i cliché di orologi e cioccolato, la Svizzera rivela la sua ricchezza.
Una nazione di transizioni
Con quattro lingue ufficiali e una forte autonomia cantonale, non esiste un’unica Svizzera. Né un solo modo di conoscerla. In questo viaggio abbiamo scelto di evitare le grandi città e di concentrarci sul sud del paese.
Per due settimane abbiamo viaggiato sui suoi famosi treni: precisi, eleganti, silenziosi. Abbiamo aggiunto funicolari che risalgono le montagne, trenini a cremagliera e battelli che tracciano rotte tra rive millenarie. Abbiamo scoperto che la Svizzera si comprende attraverso le transizioni: da un cantone all’altro, da una lingua all’altra, dalla neve ai fiori, dal silenzio alle feste di strada con musica dal vivo. Capire la Svizzera significa accettare il cambiamento come norma, e il contrasto come identità.
Dal Ticino alla linea dei ghiacciai
Il percorso è iniziato vicino al Lago di Como, al confine tra il Canton Ticino e il sud dei Grigioni, dove abbiamo preso il Bernina Express verso St. Moritz.
Il treno sale dalla Val Poschiavo, una regione verde e mediterranea che, pur essendo completamente svizzera, parla italiano e vive al proprio ritmo. Le sue terrazze agricole e il paesaggio dolce contrastano con il mondo glaciale che si incontra in quota.

Il passaggio per l’Ospizio Bernina (2.253 m) non è solo il punto più alto del percorso, ma anche una soglia geografica. Accanto, il Lago Bianco—biancastro per i minerali del ghiacciaio Palü—si contrappone al più cupo Lago Nero, come se anche l’acqua parlasse con toni diversi. La differenza cromatica racconta una biforcazione: le acque del Bianco scorrono verso l’Adriatico, quelle del Nero verso il Danubio e il Mar Nero. In quel punto cambia persino la lingua: lasciamo l’italiano ed entriamo nella zona romancia dei Grigioni.
St. Moritz e il lusso senza appartenenza
In contrasto con l’Italia, St. Moritz ci è sembrata una città un po’ senz’anima. Forse per la distanza imposta dal lusso estremo; forse per la fine della stagione invernale. Quando l’appartenenza si misura con i consumi, il luogo perde spessore.
Abbiamo preferito l’immagine del ghiaccio del lago che cedeva al sole primaverile, e passeggiare intorno per osservare le montagne da ogni angolo. È stata una pausa tattica: il giusto per osservare senza lasciarci assorbire.
Il Glacier Express e la storia in movimento
La mattina successiva abbiamo preso il Glacier Express, il treno più iconico della Svizzera. Per otto ore non abbiamo solo attraversato il paese: è stato più di un tragitto, è stato uno spettacolo.
Dal vuoto geometrico della Gola del Reno all’Oberalpass innevato, dove si sente solo il vento. A Disentis, il monastero più antico del cantone ci ha insegnato che la parola münster—già sentita tante volte nella Foresta Nera—deriva dal latino monasterium: prima della Confederazione c’erano vita, affreschi e architettura a cipolla.
A Trun fu firmata nel XIV secolo la pace che avrebbe dato origine alla Svizzera unificata. Ad Andermatt, dove confluiscono treni, strade e tunnel, si trova il passo del San Gottardo, colonna vertebrale del paese.
Ogni finestra del treno ci insegnava qualcosa: un piatto tipico (capuns), un tunnel di 17 chilometri, un dato energetico (il 60% dell’elettricità svizzera proviene dall’acqua e le centrali nucleari chiuderanno nel 2025). Ogni dettaglio non era solo informazione: era parte del modo in cui la Svizzera si lascia conoscere. Tutto aveva peso. Tutto aveva forma.
Zermatt: il villaggio alpino per eccellenza
Arrivare a Zermatt è stato entrare in un’altra dimensione. Il Cervino, onnipresente, sembrava custodire non solo il confine con l’Italia, ma anche gli sciatori che ancora godevano di una stagione prolungata. La neve tardiva aveva accumulato più di cinque metri trasformati in un manto che scendeva ancora lungo i pendii.

Abbiamo camminato tra antiche case di legno scuro con basamenti in pietra, non solo a Zmutt ma anche nel centro del paese, dove l’antico convive con la sofisticazione tecnica del presente.
Nelle camminate verso Furi abbiamo attraversato due villaggi dove abbiamo imparato che queste costruzioni del XV secolo—antichi rifugi di pastori e contadini—erano rialzate su pilastri con pietre rotonde, progettate per impedire il passaggio dei roditori. Le pareti di larice, annerite dal tempo, restano solide; i tetti di pietra proteggono la struttura per secoli.
Un piccolo museo sui coltivi d’altura ci ha insegnato del segale, della transumanza e della vita dura di chi abitava questi pendii molto prima del turismo. La Svizzera non è stata sempre ricca: è stata, prima di tutto, resistente.
quasi invisibile. Il moderno e silenzioso Matterhorn Glacier Paradise, raggiungibile in funivia, ci ha portati a 3.883 metri: il punto più alto d’Europa accessibile senza camminare. Da lì, con qualche grado sotto zero, abbiamo contemplato più di trenta vette oltre i 4.000 metri e quattordici ghiacciai che si estendono tra Svizzera, Italia e Francia.
Al contrario, la vecchia ferrovia a cremagliera per il Gornergrat ci ha portato a 3.089 metri. La vista ha rivelato nuove cime e altri volti del Cervino. Avevamo programmato di fermarci due ore, ma abbiamo dedicato l’intera giornata. Non solo per l’imponente presenza del Cervino, ma anche per le altre cime che si aprono da esso come un anfiteatro glaciale.
La neve accumulata rendeva impossibile seguire i sentieri tracciati, ma rivelava un altro modo di guardare la montagna: il silenzio del ghiacciaio del Gorner, disteso come una lingua scricchiolante, imponeva una pausa. Facevamo un picnic su una panchina tra i ghiacci, mentre alcuni uccelli di montagna – i corvi alpini – cercavano di rubarci il pranzo. Ascoltavamo il vento che filtrava tra le cime, in un silenzio che non era assenza di suono, ma presenza totale dell’ambiente.
Abbiamo visitato anche il cimitero degli alpinisti, dove le date delle prime spedizioni parlavano di rischio, abilità e determinazione. Abbiamo imparato qualcosa di affascinante: mentre il versante svizzero è stabilmente occupato, quello italiano non ha insediamenti, sebbene vi sia una complessa rete di sentieri, rifugi e ristoranti d’alta quota. Questa montagna “vuota” è, in realtà, intensamente abitata dallo sport.
Abbiamo condiviso una zuppa locale con gli sciatori che arrivavano dall’altra parte. La “zuppa della nonna”, come veniva pubblicizzata in tedesco, era più di un semplice cibo: era un punto d’incontro, un gesto condiviso in un territorio esplorato con gli scarponi o con gli sci.
Vaud e la Riviera svizzera
Da lì, abbiamo fatto le valigie per attraversare il confine e raggiungere il Canton Vaud. Non è stato solo un cambio di lingua. Tutto è diventato più dolce: le terrazze del Lavaux, i sentieri costeggiati da fiori selvatici – e altri meticolosamente piantati – le barche ancorate di fronte ai villaggi in stile Art Nouveau.
A Les Avants abbiamo cercato narcisi; a Clarens abbiamo fatto un’escursione tra i tigli; e sul Lago di Ginevra abbiamo navigato su un battello Belle Époque, alimentato dai suoi macchinari originali a gasolio, come un museo della vela. I bicchieri di vino locale serviti sulle sedie a sdraio sul ponte superiore hanno reso la gita indimenticabile.
Montreux ci ha sorpreso con la sua esposizione floreale. Tulipani di ogni forma e colore, disposti con un’estetica quasi curata da un curatore, hanno conferito al lungomare l’atmosfera di un giardino in movimento. Andare a correre di buon mattino è stato rivelatorio: ho visto i bulbi cambiare colore, nuovi profumi emergere dalle piante aromatiche e la primavera organizzarsi con metodo e affetto.
Più in alto sui pendii, abbiamo visto ciò che la neve tardiva aveva nascosto a Zermatt: la transumanza. Pecore e mucche con i loro campanacci, salendo verso i pascoli freschi, scandivano la stagione con antica precisione.

Lavaux era forse l’incarnazione perfetta dei contrasti svizzeri: un vigneto coltivato da secoli, dove il 98% del vino prodotto viene consumato all’interno del Paese. Una perla locale che prospera grazie a tre soli: il sole nel cielo, il riflesso del lago e il calore trattenuto dalle pietre delle sue terrazze al tramonto.
Tutto sembra essere frutto di una logica segreta: quella della cura.

Confini, fortezze e l’arte del passaggio
Prima di diventare una meta turistica, la Svizzera era un luogo di passaggio, una geografia attraversata, ma anche contesa. Abbiamo visitato castelli come Chillon, sulle rive del Lago di Ginevra, e Bellinzona, la cui triade fortificata – Castelgrande, Montebello e Sasso Corbaro – racconta di un’epoca in cui i confini non erano una linea astratta, ma punti di osservazione, controllo e protezione.
A Bellinzona, l’impianto strategico di queste fortezze risponde a una logica di sorveglianza che risale all’epoca romana, ma che fu perfezionata dai duchi di Milano, in particolare dai Visconti e poi dagli Sforza, nel XV secolo.
Più a ovest, il Castello di Chillon controllava il traffico sulla stretta strada a picco sul mare tra i cantoni di Vaud e Vallese. Non è un caso che il Passo di Saint-Maurice, uno degli storici punti di accesso all’alta valle del Rodano, si trovi proprio lì.

Queste fortezze ci ricordano che le Alpi non sono solo una barriera naturale, ma una rete di corridoi strategici. La Svizzera è una terra di passi: San Gottardo, Bernina, Sempione, Oberalp. Luoghi attraverso i quali persone, eserciti e merci transitavano, a volte lentamente, a volte furtivamente, a volte con spirito guerriero.
Oggi, dove c’erano posti di dogana, ci sono piattaforme. Dove c’erano posti di blocco, ci sono valichi. Quei valichi ora collegano
Lugano e Locarno: esiste anche il sud
Di ritorno nella Svizzera italiana, Lugano ci ha ricordato che anche il sud esiste. Abbiamo camminato lungo il suo viale principale, tra eleganti negozi e facciate signorili, fino a raggiungere Parco Ciani, dove le panchine si affacciano sull’acqua in tutta serenità. Abbiamo noleggiato una barca e abbiamo navigato oltre il confine italiano: un confine non segnato, ma visibile nel tono delle case, nella forma delle colline e nella musica di sottofondo.
Siamo finiti a Locarno, tra la fiera dei food truck in Piazza Grande e la solennità del Santuario della Madonna del Sasso. Costruito dopo che frate Bartolomeo Piatti credette di vedere la Vergine dalla roccia – il sasso – nel 1480. La città è cresciuta sotto, e oggi, mentre lassù si celebra la messa in una chiesa barocca, tutto sotto vibra del profumo del cibo di strada. Questa simultaneità – tra l’elevato e il terreno, lo svizzero e l’italiano, il preciso e il vissuto – è stata, forse, la migliore sintesi del viaggio.
Valle Verzasca: una Svizzera senza vetrine
Concludiamo il tour visitando la Valle Verzasca, incentrata sul fiume color smeraldo che le dà il nome. I suoi villaggi in pietra sono attraversati dal Ponte dei Salti, un ponte medievale a due arcate a Lavertezzo che sembra uscito da una fiaba.

Durante l’escursione alla cascata di Sonogno, ci siamo imbattuti in sculture ricavate da tronchi d’albero: parte di un percorso artistico che unisce natura, cultura e arte contemporanea con un profondo rispetto per l’ambiente alpino. Un addio più autentico. Più rurale. Una Svizzera senza vetrine.
Viaggiare attraverso la Svizzera non significa seguire una linea retta. Significa accettare che i Paesi si raccontano anche a strati: dai loro treni, certo, ma anche dalle loro valli; dalle loro infrastrutture impeccabili. Da un autobus puntuale a una funicolare che sembra fluttuare tra le vette, ma anche dal modo in cui tutto si fonde con il ritmo del paesaggio.
La Svizzera non si impone: lavora con precisione, ma si percepisce con stupore.
Se questa lettura ti ha fatto venire voglia di viaggiare lentamente, o di guardare il mondo che già conosci in modo diverso, condividila con qualcuno che apprezza anche lui i ritmi lenti, i buoni treni e le storie raccontate a strati.
I miei itinerari sono pensati proprio per questo: per farti provare emozioni, stupirti, imparare e tornare con ricordi incomparabili.
Se sogni il tuo prossimo viaggio, scrivimi.

Vuoi ricevere la mia newsletter? Iscriviti a "El Baùl Cultural" sul mio Substack!
Uno spazio settimanale di riflessione in cui condivido le mie esperienze, espresse attraverso le mie passioni: lettura, viaggi, cinema, arte, politica e tecnologia.