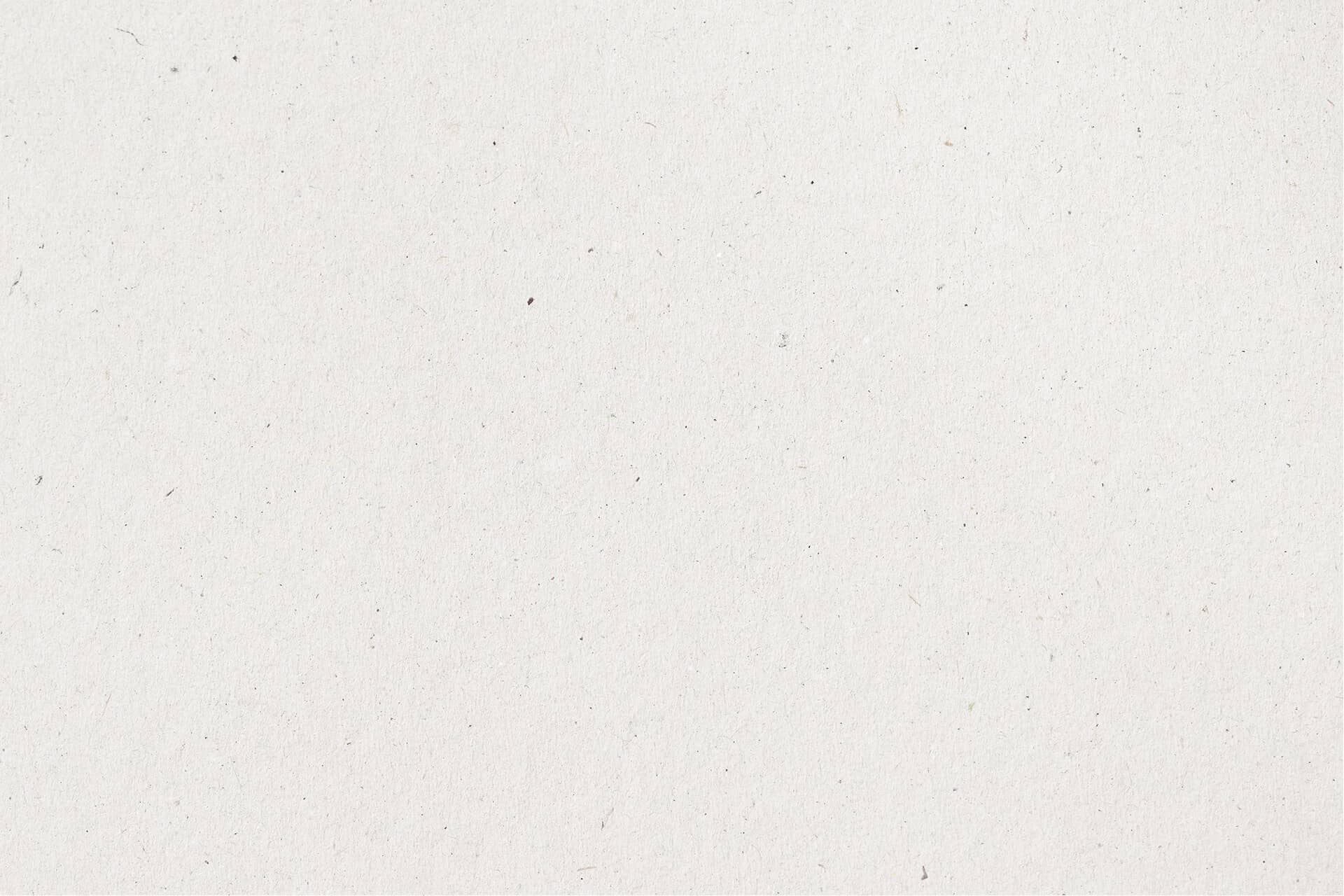
Svizzera senza fretta: treni, valli e l’eleganza di un paese che funziona senza ostentazioni

Un taccuino lento di treni panoramici, villaggi alpini e fortezze medievali. Oltre i cliché di orologi e cioccolato, la Svizzera rivela la sua ricchezza.
Una nazione di transizioni
Con quattro lingue ufficiali e una forte autonomia cantonale, non esiste un’unica Svizzera. Né un solo modo di conoscerla. In questo viaggio abbiamo scelto di evitare le grandi città e di concentrarci sul sud del paese.
Per due settimane abbiamo viaggiato sui suoi famosi treni: precisi, eleganti, silenziosi. Abbiamo aggiunto funicolari che risalgono le montagne, trenini a cremagliera e battelli che tracciano rotte tra rive millenarie. Abbiamo scoperto che la Svizzera si comprende attraverso le transizioni: da un cantone all’altro, da una lingua all’altra, dalla neve ai fiori, dal silenzio alle feste di strada con musica dal vivo. Capire la Svizzera significa accettare il cambiamento come norma, e il contrasto come identità.
Dal Ticino alla linea dei ghiacciai
Il percorso è iniziato vicino al Lago di Como, al confine tra il Canton Ticino e il sud dei Grigioni, dove abbiamo preso il Bernina Express verso St. Moritz.
Il treno sale dalla Val Poschiavo, una regione verde e mediterranea che, pur essendo completamente svizzera, parla italiano e vive al proprio ritmo. Le sue terrazze agricole e il paesaggio dolce contrastano con il mondo glaciale che si incontra in quota.

Il passaggio per l’Ospizio Bernina (2.253 m) non è solo il punto più alto del percorso, ma anche una soglia geografica. Accanto, il Lago Bianco—biancastro per i minerali del ghiacciaio Palü—si contrappone al più cupo Lago Nero, come se anche l’acqua parlasse con toni diversi. La differenza cromatica racconta una biforcazione: le acque del Bianco scorrono verso l’Adriatico, quelle del Nero verso il Danubio e il Mar Nero. In quel punto cambia persino la lingua: lasciamo l’italiano ed entriamo nella zona romancia dei Grigioni.
St. Moritz e il lusso senza appartenenza
In contrasto con l’Italia, St. Moritz ci è sembrata una città un po’ senz’anima. Forse per la distanza imposta dal lusso estremo; forse per la fine della stagione invernale. Quando l’appartenenza si misura con i consumi, il luogo perde spessore.
Abbiamo preferito l’immagine del ghiaccio del lago che cedeva al sole primaverile, e passeggiare intorno per osservare le montagne da ogni angolo. È stata una pausa tattica: il giusto per osservare senza lasciarci assorbire.
Il Glacier Express e la storia in movimento
La mattina successiva abbiamo preso il Glacier Express, il treno più iconico della Svizzera. Per otto ore non abbiamo solo attraversato il paese: è stato più di un tragitto, è stato uno spettacolo.
Dal vuoto geometrico della Gola del Reno all’Oberalpass innevato, dove si sente solo il vento. A Disentis, il monastero più antico del cantone ci ha insegnato che la parola münster—già sentita tante volte nella Foresta Nera—deriva dal latino monasterium: prima della Confederazione c’erano vita, affreschi e architettura a cipolla.
A Trun fu firmata nel XIV secolo la pace che avrebbe dato origine alla Svizzera unificata. Ad Andermatt, dove confluiscono treni, strade e tunnel, si trova il passo del San Gottardo, colonna vertebrale del paese.
Ogni finestra del treno ci insegnava qualcosa: un piatto tipico (capuns), un tunnel di 17 chilometri, un dato energetico (il 60% dell’elettricità svizzera proviene dall’acqua e le centrali nucleari chiuderanno nel 2025). Ogni dettaglio non era solo informazione: era parte del modo in cui la Svizzera si lascia conoscere. Tutto aveva peso. Tutto aveva forma.
Zermatt: il villaggio alpino per eccellenza
Arrivare a Zermatt è stato entrare in un’altra dimensione. Il Cervino, onnipresente, sembrava custodire non solo il confine con l’Italia, ma anche gli sciatori che ancora godevano di una stagione prolungata. La neve tardiva aveva accumulato più di cinque metri trasformati in un manto che scendeva ancora lungo i pendii.

Abbiamo camminato tra antiche case di legno scuro con basamenti in pietra, non solo a Zmutt ma anche nel centro del paese, dove l’antico convive con la sofisticazione tecnica del presente.
Nelle camminate verso Furi abbiamo attraversato due villaggi dove abbiamo imparato che queste costruzioni del XV secolo—antichi rifugi di pastori e contadini—erano rialzate su pilastri con pietre rotonde, progettate per impedire il passaggio dei roditori. Le pareti di larice, annerite dal tempo, restano solide; i tetti di pietra proteggono la struttura per secoli.
Un piccolo museo sui coltivi d’altura ci ha insegnato del segale, della transumanza e della vita dura di chi abitava questi pendii molto prima del turismo. La Svizzera non è stata sempre ricca: è stata, prima di tutto, resistente.
quasi invisibile. Il moderno e silenzioso Matterhorn Glacier Paradise, raggiungibile in funivia, ci ha portati a 3.883 metri: il punto più alto d’Europa accessibile senza camminare. Da lì, con qualche grado sotto zero, abbiamo contemplato più di trenta vette oltre i 4.000 metri e quattordici ghiacciai che si estendono tra Svizzera, Italia e Francia.
Al contrario, la vecchia ferrovia a cremagliera per il Gornergrat ci ha portato a 3.089 metri. La vista ha rivelato nuove cime e altri volti del Cervino. Avevamo programmato di fermarci due ore, ma abbiamo dedicato l’intera giornata. Non solo per l’imponente presenza del Cervino, ma anche per le altre cime che si aprono da esso come un anfiteatro glaciale.
La neve accumulata rendeva impossibile seguire i sentieri tracciati, ma rivelava un altro modo di guardare la montagna: il silenzio del ghiacciaio del Gorner, disteso come una lingua scricchiolante, imponeva una pausa. Facevamo un picnic su una panchina tra i ghiacci, mentre alcuni uccelli di montagna – i corvi alpini – cercavano di rubarci il pranzo. Ascoltavamo il vento che filtrava tra le cime, in un silenzio che non era assenza di suono, ma presenza totale dell’ambiente.
Abbiamo visitato anche il cimitero degli alpinisti, dove le date delle prime spedizioni parlavano di rischio, abilità e determinazione. Abbiamo imparato qualcosa di affascinante: mentre il versante svizzero è stabilmente occupato, quello italiano non ha insediamenti, sebbene vi sia una complessa rete di sentieri, rifugi e ristoranti d’alta quota. Questa montagna «vuota» è, in realtà, intensamente abitata dallo sport.
Abbiamo condiviso una zuppa locale con gli sciatori che arrivavano dall’altra parte. La «zuppa della nonna», come veniva pubblicizzata in tedesco, era più di un semplice cibo: era un punto d’incontro, un gesto condiviso in un territorio esplorato con gli scarponi o con gli sci.
Vaud e la Riviera svizzera
Da lì, abbiamo fatto le valigie per attraversare il confine e raggiungere il Canton Vaud. Non è stato solo un cambio di lingua. Tutto è diventato più dolce: le terrazze del Lavaux, i sentieri costeggiati da fiori selvatici – e altri meticolosamente piantati – le barche ancorate di fronte ai villaggi in stile Art Nouveau.
A Les Avants abbiamo cercato narcisi; a Clarens abbiamo fatto un’escursione tra i tigli; e sul Lago di Ginevra abbiamo navigato su un battello Belle Époque, alimentato dai suoi macchinari originali a gasolio, come un museo della vela. I bicchieri di vino locale serviti sulle sedie a sdraio sul ponte superiore hanno reso la gita indimenticabile.
Montreux ci ha sorpreso con la sua esposizione floreale. Tulipani di ogni forma e colore, disposti con un’estetica quasi curata da un curatore, hanno conferito al lungomare l’atmosfera di un giardino in movimento. Andare a correre di buon mattino è stato rivelatorio: ho visto i bulbi cambiare colore, nuovi profumi emergere dalle piante aromatiche e la primavera organizzarsi con metodo e affetto.
Più in alto sui pendii, abbiamo visto ciò che la neve tardiva aveva nascosto a Zermatt: la transumanza. Pecore e mucche con i loro campanacci, salendo verso i pascoli freschi, scandivano la stagione con antica precisione.

Lavaux era forse l’incarnazione perfetta dei contrasti svizzeri: un vigneto coltivato da secoli, dove il 98% del vino prodotto viene consumato all’interno del Paese. Una perla locale che prospera grazie a tre soli: il sole nel cielo, il riflesso del lago e il calore trattenuto dalle pietre delle sue terrazze al tramonto.
Tutto sembra essere frutto di una logica segreta: quella della cura.

Confini, fortezze e l’arte del passaggio
Prima di diventare una meta turistica, la Svizzera era un luogo di passaggio, una geografia attraversata, ma anche contesa. Abbiamo visitato castelli come Chillon, sulle rive del Lago di Ginevra, e Bellinzona, la cui triade fortificata – Castelgrande, Montebello e Sasso Corbaro – racconta di un’epoca in cui i confini non erano una linea astratta, ma punti di osservazione, controllo e protezione.
A Bellinzona, l’impianto strategico di queste fortezze risponde a una logica di sorveglianza che risale all’epoca romana, ma che fu perfezionata dai duchi di Milano, in particolare dai Visconti e poi dagli Sforza, nel XV secolo.
Più a ovest, il Castello di Chillon controllava il traffico sulla stretta strada a picco sul mare tra i cantoni di Vaud e Vallese. Non è un caso che il Passo di Saint-Maurice, uno degli storici punti di accesso all’alta valle del Rodano, si trovi proprio lì.

Queste fortezze ci ricordano che le Alpi non sono solo una barriera naturale, ma una rete di corridoi strategici. La Svizzera è una terra di passi: San Gottardo, Bernina, Sempione, Oberalp. Luoghi attraverso i quali persone, eserciti e merci transitavano, a volte lentamente, a volte furtivamente, a volte con spirito guerriero.
Oggi, dove c’erano posti di dogana, ci sono piattaforme. Dove c’erano posti di blocco, ci sono valichi. Quei valichi ora collegano
Lugano e Locarno: esiste anche il sud
Di ritorno nella Svizzera italiana, Lugano ci ha ricordato che anche il sud esiste. Abbiamo camminato lungo il suo viale principale, tra eleganti negozi e facciate signorili, fino a raggiungere Parco Ciani, dove le panchine si affacciano sull’acqua in tutta serenità. Abbiamo noleggiato una barca e abbiamo navigato oltre il confine italiano: un confine non segnato, ma visibile nel tono delle case, nella forma delle colline e nella musica di sottofondo.
Siamo finiti a Locarno, tra la fiera dei food truck in Piazza Grande e la solennità del Santuario della Madonna del Sasso. Costruito dopo che frate Bartolomeo Piatti credette di vedere la Vergine dalla roccia – il sasso – nel 1480. La città è cresciuta sotto, e oggi, mentre lassù si celebra la messa in una chiesa barocca, tutto sotto vibra del profumo del cibo di strada. Questa simultaneità – tra l’elevato e il terreno, lo svizzero e l’italiano, il preciso e il vissuto – è stata, forse, la migliore sintesi del viaggio.
Valle Verzasca: una Svizzera senza vetrine
Concludiamo il tour visitando la Valle Verzasca, incentrata sul fiume color smeraldo che le dà il nome. I suoi villaggi in pietra sono attraversati dal Ponte dei Salti, un ponte medievale a due arcate a Lavertezzo che sembra uscito da una fiaba.

Durante l’escursione alla cascata di Sonogno, ci siamo imbattuti in sculture ricavate da tronchi d’albero: parte di un percorso artistico che unisce natura, cultura e arte contemporanea con un profondo rispetto per l’ambiente alpino. Un addio più autentico. Più rurale. Una Svizzera senza vetrine.
Viaggiare attraverso la Svizzera non significa seguire una linea retta. Significa accettare che i Paesi si raccontano anche a strati: dai loro treni, certo, ma anche dalle loro valli; dalle loro infrastrutture impeccabili. Da un autobus puntuale a una funicolare che sembra fluttuare tra le vette, ma anche dal modo in cui tutto si fonde con il ritmo del paesaggio.
La Svizzera non si impone: lavora con precisione, ma si percepisce con stupore.
Se questa lettura ti ha fatto venire voglia di viaggiare lentamente, o di guardare il mondo che già conosci in modo diverso, condividila con qualcuno che apprezza anche lui i ritmi lenti, i buoni treni e le storie raccontate a strati.
I miei itinerari sono pensati proprio per questo: per farti provare emozioni, stupirti, imparare e tornare con ricordi incomparabili.
Se sogni il tuo prossimo viaggio, scrivimi.

Vuoi ricevere la mia newsletter? Iscriviti a "El Baùl Cultural" sul mio Substack!
Uno spazio settimanale di riflessione in cui condivido le mie esperienze, espresse attraverso le mie passioni: lettura, viaggi, cinema, arte, politica e tecnologia.








